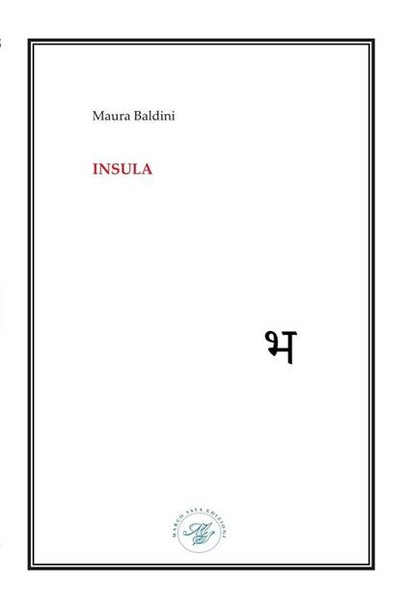Insula, il luogo che non esiste. Così lo definì Tommaso Moro nel 1516, nel battezzare la sua Utopia.
Un’isola che non c’è — ma che pulsa, vive, lampeggia, tra luce e oscurità, tra avvicinamento e fuga.
È questo il respiro che anima il poema di Maura Baldini, Islanda, in cui la parola diventa corpo, soglia, naufragio e bagliore.
L’isola – o meglio, l’insula – non è una terra, ma un’assenza che seduce. Una tensione.
Non è approdo, ma il movimento perpetuo tra l’approdare e l’invertire la rotta.
Esiste, ci chiede la poetessa, un luogo dell’anima in cui veramente si possa attraccare?
Su questo testo aleggia la domanda che non chiede risposte.
La parola sobbalza nel nulla, come dice la stessa autrice, e ci interroga da dentro, in quel punto cieco dove l’oscurità si fa — paradossalmente — luce.
Una luce vera, perché dolorosa, non negoziabile, e proprio per questo rivelatrice.
Maura Baldini plasma la lingua come fosse materia viva.
Scrive:
“La notte, qui, è una voglia / che sfrega dietro la rètina, / mentre il giorno imperterrito / veglia, non recede, / in un tempo di fasulla quiete.”
Il corpo della parola si trasfigura in pelle, respiro, contatto.
Eppure la poetessa ci ammonisce:
“Vieni. Avvicinati. / Insula è un simulacro, /l’ara sulla quale immolare il tempo… /”
Questa tensione tra attrazione e rifiuto, tra l’intimità del richiamo e l’inevitabilità della distanza, percorre tutto il poema.
Insula è il simulacro di un altrove irraggiungibile, ma necessario.
È, forse, lo specchio dell’umano:
“Sei tu la parabola dell’alba eterna, / l’onda immensa che si avvicina, / la speranza mai sopita / di un volto che abbraccia l’infinito.”
Baldini scrive come chi ha visto l’abisso.
Il lessico non consola: tormenta.
In una delle immagini più memorabili, leggiamo:
“Come l’acqua senza requie / benediciamo l’antitesi, / e senza requie negandoci / incubiamo il desiderio / di una perfezione inferiore.”
Qui si tocca il cuore contraddittorio del poema: la separatezza come condizione dell’essere.
Il bisogno, struggente, di tornare fusi con gli elementi – aria, fuoco, acqua, terra – e l’impossibilità di farlo senza smarrirsi.
Respirare, dunque, significa anche separarsi.
Sopravvivere.
Forse morire a un ideale per rinascere nel limite.
Il poema si chiude come un salmo laico:
un invito alla requie,
ma anche un canto spezzato di chi sa che la beatitudine è solo un attimo.
Un attimo che si dissolve nella bellezza oltraggiata dell’oscurità.
Come in un’antica litania, ci restano solo i cori, i canti dell’essere,
persi – eppure eternamente presenti – nel mare dell’assenza.
Un poema intenso, dicotomico, essenziale e crudele.
Una poesia che ferisce e purifica,
che non consola ma trasfigura.
Che ci mostra, infine,
la possibilità dell’infinito in ciò che più ci separa da esso.
*
ALCUNI TESTI ESTRATTI DA “INSULA”
X
Gullfoss
(La cascata d’oro)
…mentre tutto là attorno è dilaniato dalle acque
infuriate, innalza serenamente i suoi fulgidi colori
con tutti i loro raggi intatti, e sembra, tra l’orrore
della scena, l’Amore che sorveglia la Follia
con immutabile aspetto (1).
(George Gordon Byron)
A sud-ovest dell’isola,
dove il vento è il solo confine,
dove la terra si spacca, collassa,
per inseguire il proprio centro,
e i crepacci germogliano verdi,
fra caglio zolfino e salice lanoso,
proprio lì si consuma la corsa verso l’oceano
del fiume Hvita, che prova a morire due volte.
Due volte muore cadendo,
in un averno d’acqua e fragore.
E cadendo al cielo ascende,
innalzando cattedrali d’oro e vapore.
Allora il corpo d’improvviso
s’addensa, cerca una via d’uscita,
l’idioma della caduta,
il corpo beve
dalle ciglia fino all’unghia,
beve nei pori stregati
dall’aspersione della gocciolatura.
E nel luminare dell’acqua
può finalmente morire,
morire il terrore dell’eterno precipitare,
morire ogni lapide imposta,
morire la prestanza e la forza.
Oltre le forre,
le scarpinate muschiate,
oltre l’inferno
delle correnti ghiacciate,
muore il tuo corpo ancora
per rinascere oceano
nella volontà che annega
la follia di quel nome.
*
XI
Al di là del buio
Mi sono persa,
mi sono persa, nei boschi
di tutta questa luce.
(Sylvia Plath)
“È più grande di così” (2)
l’oceano sul quale soffia questa notte,
più grande di così
l’assenza che ora scintilla.
Perché tutto, nel tacere di quel nome,
è un tremore, il mondo che vacilla,
un’onda malcerta
che prima ancora di levarsi implode.
E se a nulla servisse perdere tutto
per ricominciare?
Guarda: la neve è ancora assente
in questo bosco invisibile
di una luce incredula; eppure,
seppellisce ombre nei covili,
sparge consolazioni,
simulacri di salvezza,
spiriti mancanti
che paiono possedimenti.
Ma noi, sulla coda del buio,
sentiamo in quel nome
una protuberanza del cuore,
e attendiamo che una luce la sfiori.
*
XXIII
Un tragitto
Non voglio la bellezza,
voglio l’identità.
(Clarice Lispector)
Solitudine d’asfalto sotto
sciami di luce scostanti.
Sulla sinistra si spalanca
il volto vasto dell’oceano.
Le unghiate del vento
sfarinano la rena, la sabbia
è un assalto nero agli occhi.
Occhi come resti vulcanici,
indocili testimoni
delle furie oceaniche,
mentre la costa rifrange
l’ultimo sogno,
l’estremo tentativo di trafiggere
l’ombra bugiarda che si veste di sole.
*
XXX
Il miraggio di Penelope
Per il midollo del tuo cranio
che esercita passioni senza custodirle
io parlo.
(Amelia Rosselli)
Parlo, sola –
e torno ai fianchi del tuo sguardo, a cercare
nella ritirata il miracolo della diffrazione.
Oltre l’angolo opaco del cuore albeggia
una luce obliqua, il miraggio di Penelope.
Lunga fu la nostra notte in sogno, l’accoppiarsi
di due verdi prigioni, la disputa
di due glauchi gabbiani nati prima del mare.
Ma ora, nell’oscuro ghiaccio, un volto
batte, va alla deriva,
muore,
fantasticando il punto di fusione.
*
XXXV
Skógafoss
(Cascata dei boschi)
Ti prego, levami come un’onda, come
una foglia o una nuvola. Cado
sopra le spine della vita e sanguino!
(Percy Bysshe Shelley)
Mentre avanziamo in una nebbia randagia,
i corpi franti da una luce nascosta,
la cascata aspetta, nella crepa rossiccia –
oltre i declivi muschiati aspetta –
è un tempio di bosco, una offerta.
Siamo stati assenze, chiarori estenuanti
il delirio volitivo dei venti.
Siamo stati lo strappo – e la sutura,
la nostra vita, incessante invaiatura.
Ma dov’è ora la notte, dov’è la notte
che tutto acquatta, e dove il buio
in cui moriamo ciò che in luce siamo?
Avanza con noi lo smarrimento,
ha il cuore bianco di un pianto.
Avanza con noi la parola data,
il cerchio finito, il ritorno al primo vagito.
Eppure, siamo stanchi
di attese, di cancri e di ganci,
siamo stanchi dei palchi e dei proclami,
delle ceneri d’esilio, degli amori d’origami.
Il passo ha la forza di chi gravita in basso,
la memoria di chi sceglie il contrappasso.
Ma una voce chiama da un forziere di foglie.
È un invito ad attraversare, un ponte breve
oltre il semplice morire. È la siccità dei cuori
che finalmente si dà pace. Il tesoro è qui
nella schiena del figlio, arresa all’aspersione,
all’incanto dell’acqua, al giorno ultimo
che di ogni cosa sospende l’eterno annegare.
(1) I versi citati sono estratti da una lassa del quarto canto del poema Child Harold Pilgrimage, canto che George Gordon Byron scrisse per celebrare la Cascata delle Marmore, scoperta nel 1817, in occasione di un viaggio nei pressi del lago Trasimeno.
(2) Il verso è di Mario Luzi, tratto da Nel corpo oscuro della metamorfosi.
Insula
di Maura Baldini
Marco Saya Edizioni, 2025